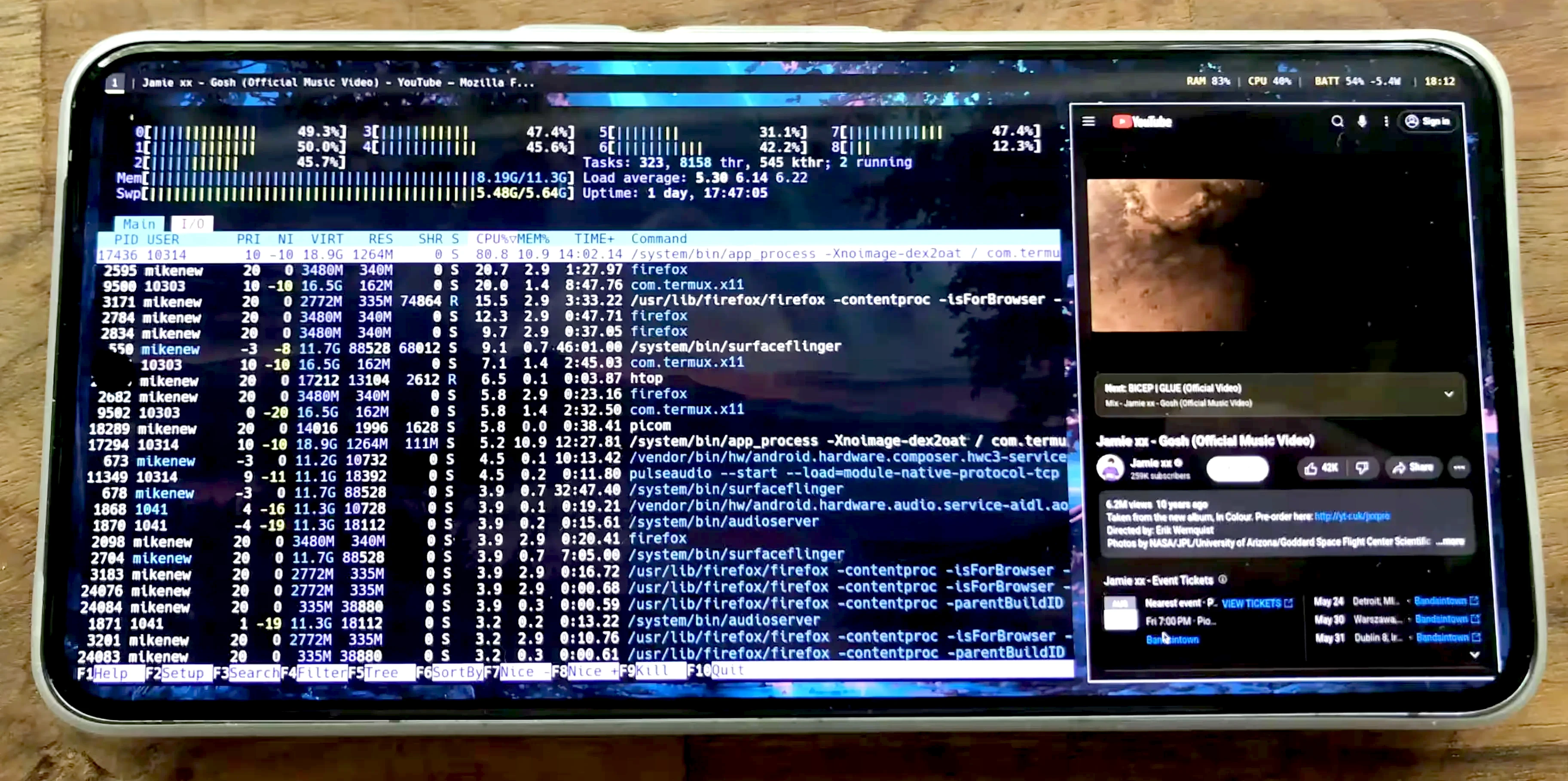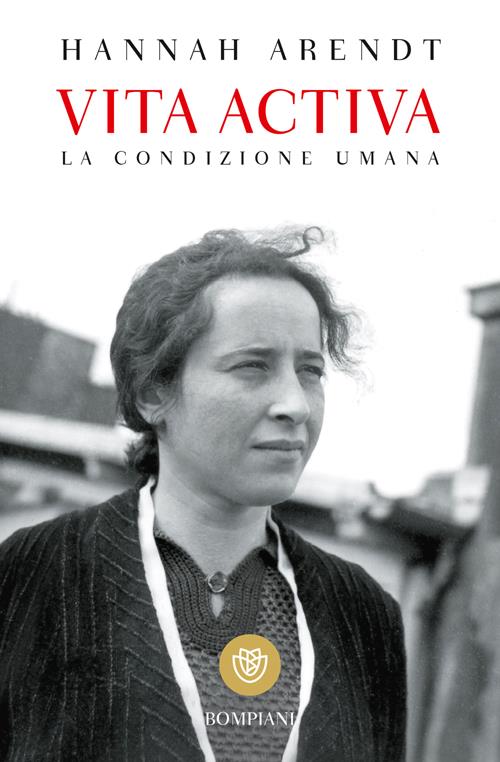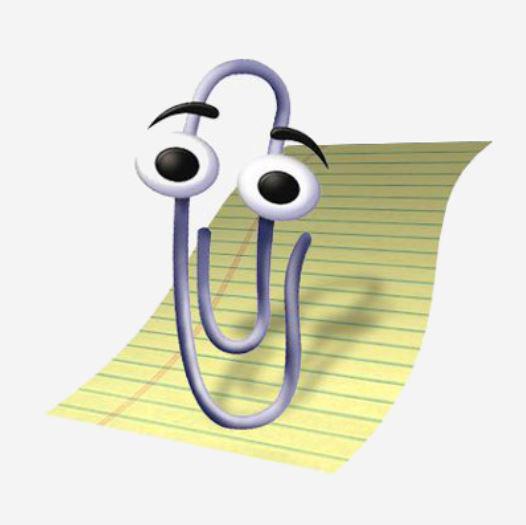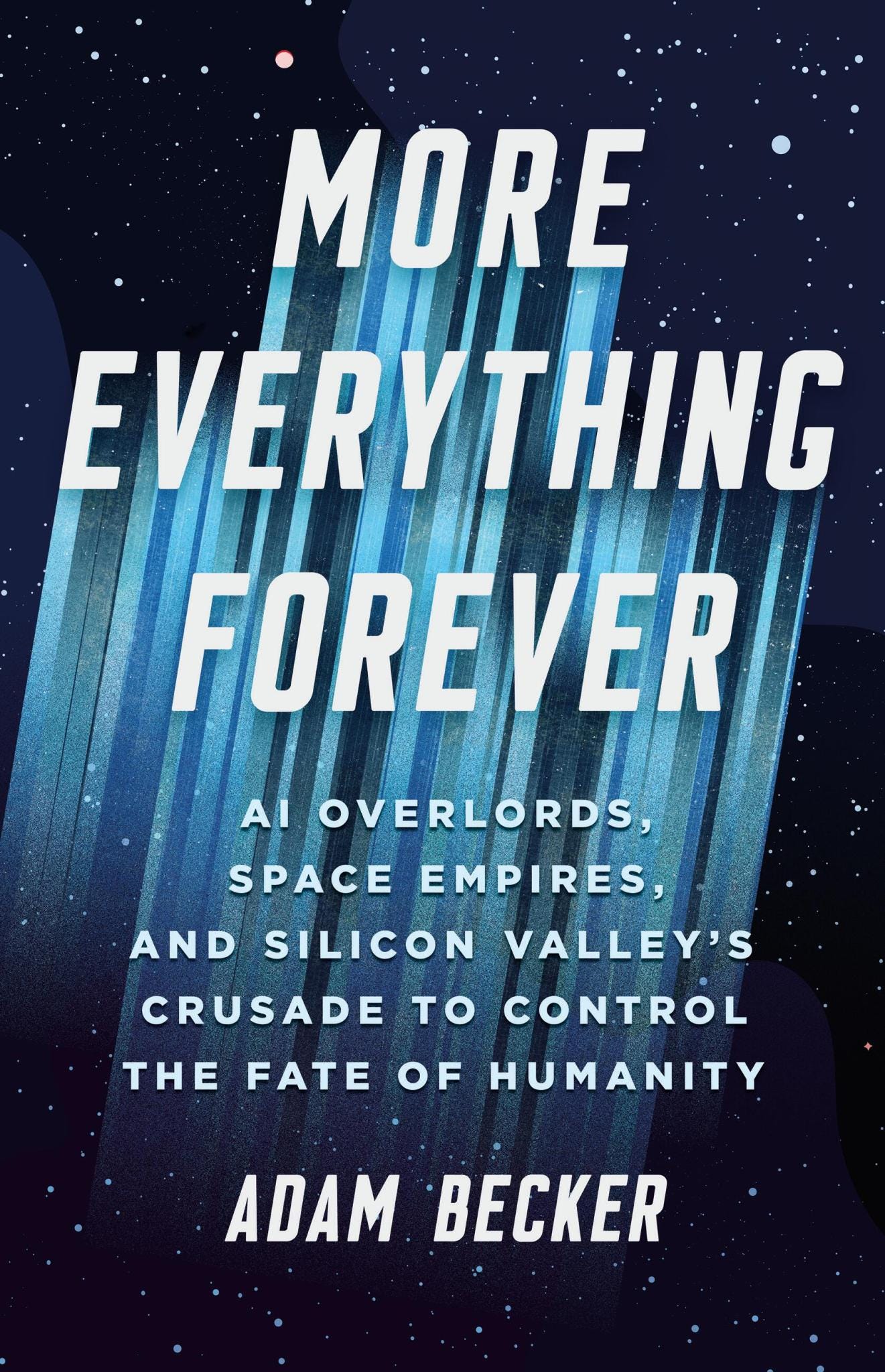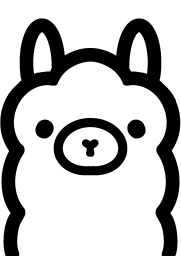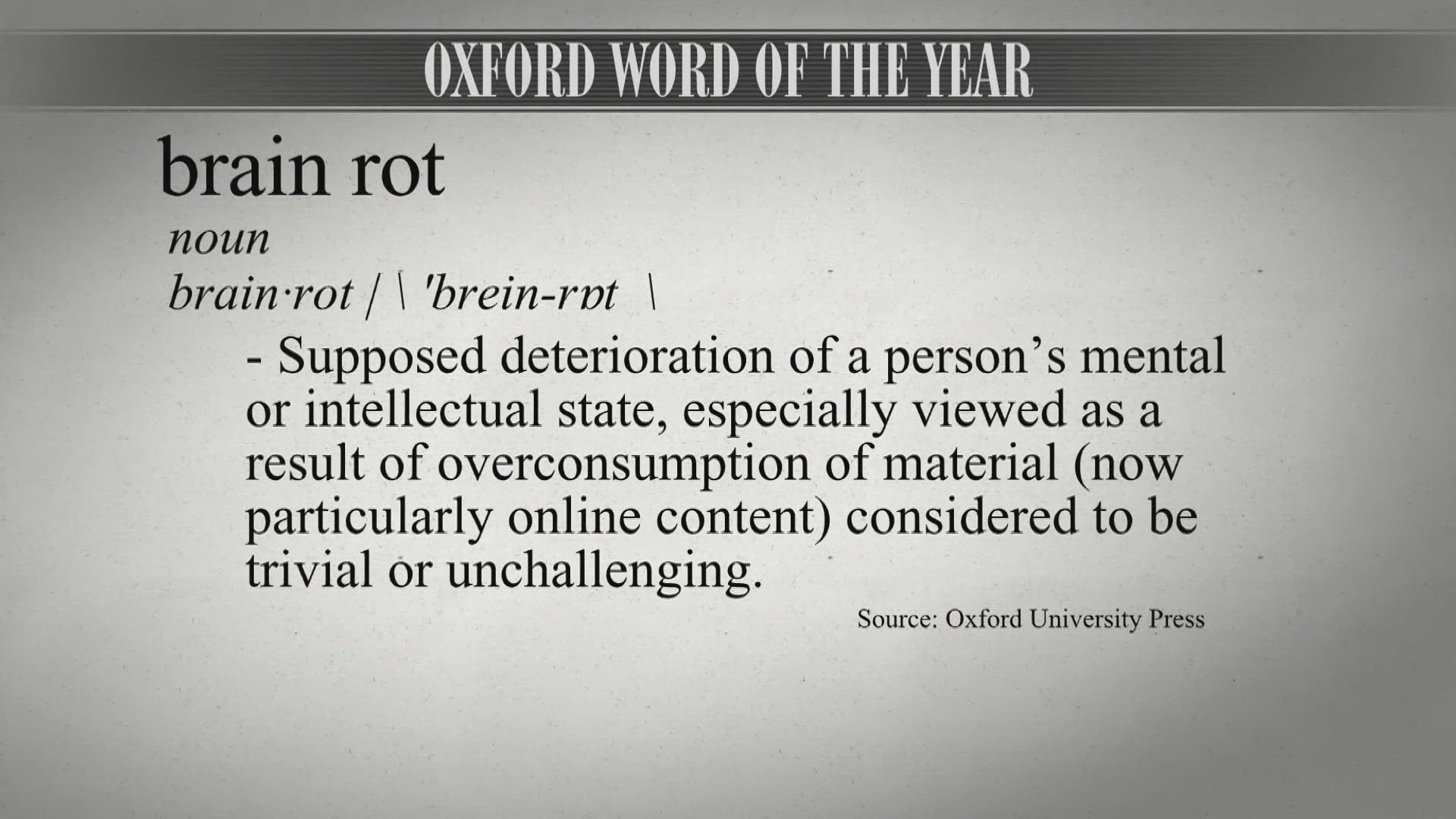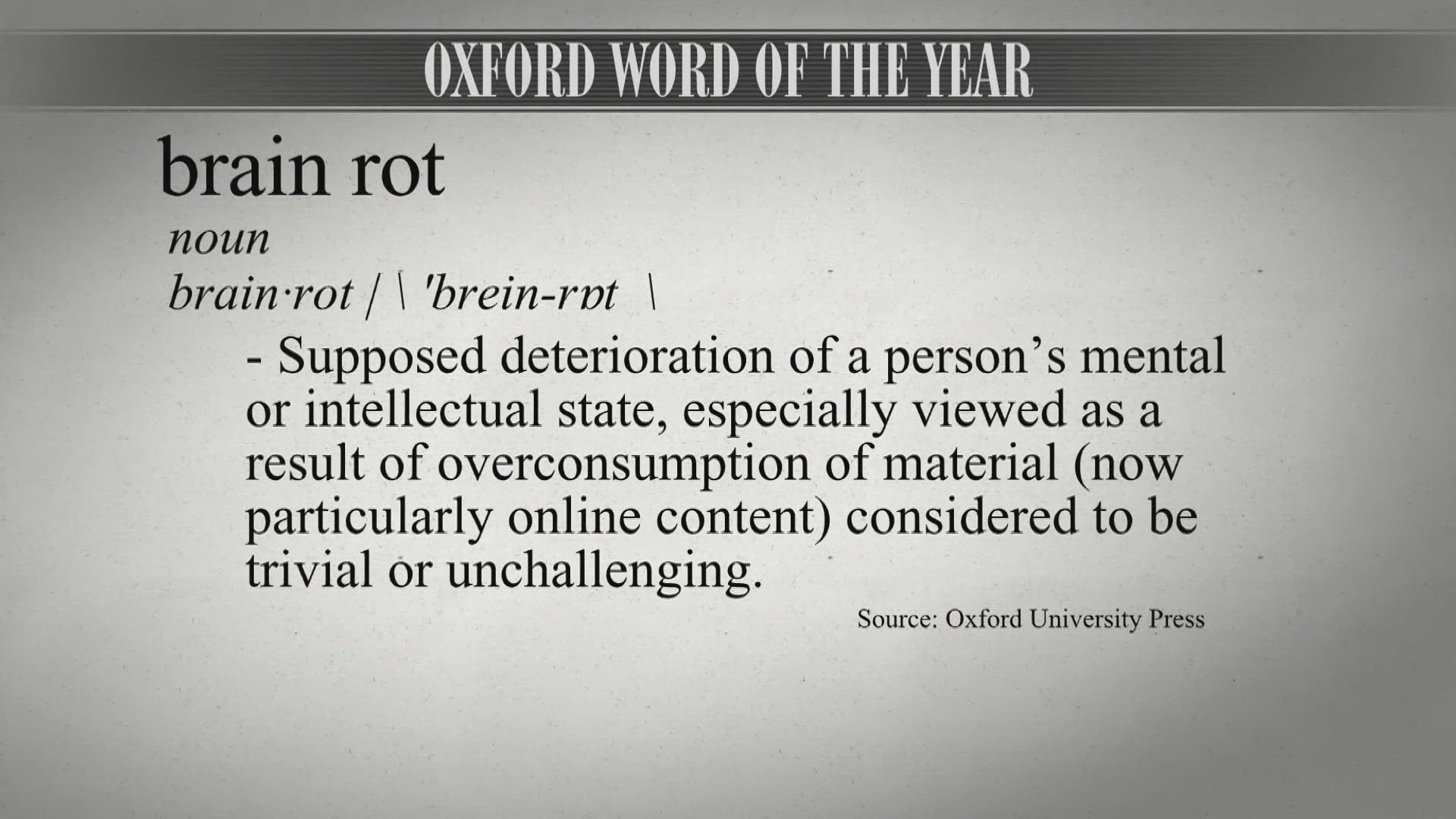
Brain Rot è la parola dell'anno. Si riferisce al “presunto deterioramento dello stato mentale o intellettuale di una persona, visto soprattutto come il risultato di un consumo eccessivo di materiale (ora in particolare di contenuti online) considerato banale o poco impegnativo. Anche: qualcosa caratterizzato come suscettibile di portare a tale deterioramento”.
Consigli utili:
Utilizzare la modalità scala di grigi:
Rende il telefono più noioso e meno “dopaminico”.
È provato che questa modalità aiuta a ridurre l'utilizzo del telefono
È possibile utilizzare le “scorciatoie” native su iOS per pianificarle automaticamente.
Utilizzare un blocco delle app:
Il blocco nativo delle app è troppo facile da ignorare
I bloccatori di app hanno un blocco rigoroso che vi responsabilizza.
Consentono di impostare un numero di aperture al giorno.
Creare una distanza fisica:
Lasciare il telefono in carica nell'altra stanza
Cercare di non tenere il telefono in tasca per tutto il tempo
Designare aree libere dal telefono
Sostituire lo scorrimento:
Siamo abituati a prendere il telefono ogni volta che abbiamo un minuto di tempo.
Scegliete invece cose semplici da fare, come leggere, camminare o uscire all'aperto.
Impostate il blocco delle app per reindirizzarvi verso queste attività.
Il “trucco dell'elastico”:
Tenete un elastico intorno al telefono
Questo vi ricorderà di essere più attenti
Inoltre, renderà fastidioso lo scorrere del tempo.
Accettare la noia come una sensazione perfino piacevole:
La nostra mente tende a farsi prendere dal panico quando non ha qualcosa da fare.
Allenatevi a superare il panico iniziale
Dall'altra parte c'è un vero senso di calma.
Andare al nocciolo del problema:
Il motivo per cui prendiamo il telefono potrebbe essere più profondo.
Non vi sentite a vostro agio con i vostri pensieri?
Chiedetevi: “È davvero così che volete passare il vostro tempo”?
Iniziare una pratica di consapevolezza:
- La meditazione regolare può fare una grande differenza con qualsiasi dipendenza.
- Soprattutto per la dipendenza da telefono e il marciume cerebrale
- Solo 5-10 minuti al giorno possono essere un ottimo inizio.
Provare a misurare il consumo di media digitali per 12 o 24 ore:
- Una disintossicazione dal telefono può aiutare a resettare il cervello
- Può essere più facile costruire abitudini migliori con disintossicazioni occasionali
- Le app possono aiutare a disintossicarsi regolarmente
Considerate l'impatto mentale e fisico:
- La scienza dimostra chiaramente che l'uso eccessivo del telefono ha un impatto reale
- Dolori al collo e alla schiena (aumento del 500%)
- Insonnia (aumento del 68%)
Ansia e depressione (aumento del 100%)
- Riduzione della capacità di attenzione